Dal 21 dicembre al 25 marzo
A Napoli arrivano i Longobardi

Spada con impugnatura aurea, dalla mostra "Longobardi" - courtesy © Musei Civici Pavia
Samantha De Martin
22/12/2017
Napoli - Anfore, epigrafi, corni potori, gioielli di artigianato germanico irrompono nel cuore di una delle più illustri città magnogreche. Per circa tre mesi l’arte dei Longobardi dialogherà con la cultura greco-romana, fiore all’occhiello del Museo Archeologico tra i più importanti al mondo, tessendo un incontro volto a esaltare la straordinaria complessità di una regione che ha saputo affrancarsi dall’idea classica di archeologia per raccontare le sfumature luminose e illuminanti della sua variegata tradizione artistica.
Il percorso che, dopo Pavia, antica capitale del Regno longobardo, inaugura al MANN di Napoli - città bizantina, ma importante punto di riferimento economico e culturale del Ducato di Benevento - sarà l’ultima preziosa occasione per ammirare Longobardi, un popolo che cambia la storia, mostra che il 21 aprile 2018 raggiungerà l’Ermitage di San Pietroburgo, tappa finale del viaggio alla scoperta di un popolo che, a partire dal 568, anno della discesa in Italia, ha rivoluzionato l’antico tessuto storico, culturale, linguistico del Paese, sgretolando, con il suo acuminato “dente” l'intero sistema economico-sociale di impronta romana, pur cucendo, al tempo stesso, una nuova realtà politica.
Quello del popolo dalle lunghe barbe, al sud, non è un debutto, bensì un ritorno, considerati i tanti segni indelebili, lasciati nel tempo dalle genti di Alboino e Arechi II. Si pensi a Capua, Benevento e Salerno - dove Arechi, proclamatosi principe dei Longobardi, fece edificare un palazzo nel cuore della città e una fortezza sul colle che la sovrasta - le tre capitali della Langobardia minor, e si pensi all’interessante rapporto che esse intrattennero con le città costiere di Napoli, Amalfi e Gaeta, rimaste a gravitare nell’orbita dell’Impero bizantino.
Un rincontro che non vuole solo stupire, ma anche divertire, grazie ai laboratori e alle attività didattiche per bambini e famiglie - tra cacce al tesoro e scavi simulati - parlare di incontri e incroci di popoli del mare e di civiltà transalpine, profondamente diverse, ma a tratti perfettamente integrate.
L’occasione della mostra pone inoltre il MANN quale epicentro di un’importante rete di realtà campane che, ospitando una serie di itinerari e appuntamenti tematici, consentiranno di delocalizzare e di potenziare l’offerta culturale dei Longobardi, in una piena cornice regionale.
E poi ad unire la Napoli bizantina alla Campania longobarda c’era il culto comune per San Gennaro, venerato anche dai Longobardi. Il corpo del Santo, nel V secolo, era stato trasportato nell’area cimiteriale sulla collina di Capodimonte, nota ancora oggi come “Catacomba di San Gennaro”. E proprio in questo luogo, in cui era stata edificata una grande basilica a custodirne le reliquie, nel 831 il principe Sico di Benevento ne aveva trafugato i resti, mentre Napoli era sotto l’assedio dei Longobardi. Le spoglie del Santo rimasero a Benevento siano alla metà del XII secolo per tornare a Napoli nella metà del XV secolo.
Nel corso di questi tre mesi i visitatori avranno modo di assaporare il frutto di oltre 15 anni di nuove indagini archeologiche, epigrafiche e storico-politiche su siti e necropoli altomedievali, condotte da circa 50 studiosi, e di ammirare oltre 300 opere molte delle quali provenienti da un’ottantina di enti e musei.
Rispetto alla mostra tenutasi nei mesi scorsi a Pavia, quella al MANN presenta alcune novità, fortemente legate alle testimonianze che questo popolo depositò nell’attuale Campania. C'è infatti il racconto legato alla Longobardia Minor, che si arricchisce a Napoli di nuove testimonianze, con importanti opere relative soprattutto a San Vincenzo al Volturno, tra i massimi complessi monastici realizzati dai Longobardi nel sud Italia. Ci sono poi le epigrafi funerarie dei monaci Maio e Almo, della prima metà del IX secolo, prestate dal Polo Museale del Molise-Museo Archeologico di Venafro e provenienti dalla Basilica Major di San Vincenzo, o la vetratina che propone la parte superiore di una figura di Cristo composta da pannelli in vetro colorato e legatura a piombo, con particolari soluzioni ornamentali. Dall’imponente pannello pittorico dell’XI secolo che a gennaio arriverà da Venafro, con il "Tema dei profeti" alla lastra con i grifoni dall'Antiquarium di Cimitile della Diocesi di Nola, lunga quasi due metri, dal Codice virgiliano con scrittura beneventana all'Omiliario dell'XI secolo proveniente dal Duomo di Troia (Foggia), e ancora al celebre Titolus di Arechi II, frammento dell'epigrafe dettata da Paolo Diacono, proveniente dalle pareti della Cappella Palatina di Salerno, una ricchissima teoria di oggetti sfilerà tra le sale del MANN adiacenti il Salone della Meridiana, riaperte al pubblico nel 2017, dopo trent'anni.
Non mancano, in apertura del percorso, i riferimenti al contesto geopolitico - un’Italia fortemente divisa, all’arrivo dei Longobardi - e poi tracce del culto e dell’economia, con le monete utilizzate non solo come mezzo di scambio, ma anche come simbolo di ricchezza e prestigio, da sfoggiare come gioiello inserito in collane ed anelli.
In questo seducente percorso che grazie alle innovazioni della tecnologia presenta al pubblico ricostruzioni di sepolture, videomapping di monumenti e siti, postazioni immersive, sarà possibile riscoprire il fascino e l'importanza di un popolo che ha segnato un drammatico spartiacque nella storia italiana, pur cercando, al contempo, di ricostruire, su nuove basi, quell'unità perduta.
Leggi anche:
• Longobardi: una mostra "epocale" sul popolo che cambiò la storia
• Longobardi. Un popolo che cambia la storia
Il percorso che, dopo Pavia, antica capitale del Regno longobardo, inaugura al MANN di Napoli - città bizantina, ma importante punto di riferimento economico e culturale del Ducato di Benevento - sarà l’ultima preziosa occasione per ammirare Longobardi, un popolo che cambia la storia, mostra che il 21 aprile 2018 raggiungerà l’Ermitage di San Pietroburgo, tappa finale del viaggio alla scoperta di un popolo che, a partire dal 568, anno della discesa in Italia, ha rivoluzionato l’antico tessuto storico, culturale, linguistico del Paese, sgretolando, con il suo acuminato “dente” l'intero sistema economico-sociale di impronta romana, pur cucendo, al tempo stesso, una nuova realtà politica.
Quello del popolo dalle lunghe barbe, al sud, non è un debutto, bensì un ritorno, considerati i tanti segni indelebili, lasciati nel tempo dalle genti di Alboino e Arechi II. Si pensi a Capua, Benevento e Salerno - dove Arechi, proclamatosi principe dei Longobardi, fece edificare un palazzo nel cuore della città e una fortezza sul colle che la sovrasta - le tre capitali della Langobardia minor, e si pensi all’interessante rapporto che esse intrattennero con le città costiere di Napoli, Amalfi e Gaeta, rimaste a gravitare nell’orbita dell’Impero bizantino.
Un rincontro che non vuole solo stupire, ma anche divertire, grazie ai laboratori e alle attività didattiche per bambini e famiglie - tra cacce al tesoro e scavi simulati - parlare di incontri e incroci di popoli del mare e di civiltà transalpine, profondamente diverse, ma a tratti perfettamente integrate.
L’occasione della mostra pone inoltre il MANN quale epicentro di un’importante rete di realtà campane che, ospitando una serie di itinerari e appuntamenti tematici, consentiranno di delocalizzare e di potenziare l’offerta culturale dei Longobardi, in una piena cornice regionale.
E poi ad unire la Napoli bizantina alla Campania longobarda c’era il culto comune per San Gennaro, venerato anche dai Longobardi. Il corpo del Santo, nel V secolo, era stato trasportato nell’area cimiteriale sulla collina di Capodimonte, nota ancora oggi come “Catacomba di San Gennaro”. E proprio in questo luogo, in cui era stata edificata una grande basilica a custodirne le reliquie, nel 831 il principe Sico di Benevento ne aveva trafugato i resti, mentre Napoli era sotto l’assedio dei Longobardi. Le spoglie del Santo rimasero a Benevento siano alla metà del XII secolo per tornare a Napoli nella metà del XV secolo.
Nel corso di questi tre mesi i visitatori avranno modo di assaporare il frutto di oltre 15 anni di nuove indagini archeologiche, epigrafiche e storico-politiche su siti e necropoli altomedievali, condotte da circa 50 studiosi, e di ammirare oltre 300 opere molte delle quali provenienti da un’ottantina di enti e musei.
Rispetto alla mostra tenutasi nei mesi scorsi a Pavia, quella al MANN presenta alcune novità, fortemente legate alle testimonianze che questo popolo depositò nell’attuale Campania. C'è infatti il racconto legato alla Longobardia Minor, che si arricchisce a Napoli di nuove testimonianze, con importanti opere relative soprattutto a San Vincenzo al Volturno, tra i massimi complessi monastici realizzati dai Longobardi nel sud Italia. Ci sono poi le epigrafi funerarie dei monaci Maio e Almo, della prima metà del IX secolo, prestate dal Polo Museale del Molise-Museo Archeologico di Venafro e provenienti dalla Basilica Major di San Vincenzo, o la vetratina che propone la parte superiore di una figura di Cristo composta da pannelli in vetro colorato e legatura a piombo, con particolari soluzioni ornamentali. Dall’imponente pannello pittorico dell’XI secolo che a gennaio arriverà da Venafro, con il "Tema dei profeti" alla lastra con i grifoni dall'Antiquarium di Cimitile della Diocesi di Nola, lunga quasi due metri, dal Codice virgiliano con scrittura beneventana all'Omiliario dell'XI secolo proveniente dal Duomo di Troia (Foggia), e ancora al celebre Titolus di Arechi II, frammento dell'epigrafe dettata da Paolo Diacono, proveniente dalle pareti della Cappella Palatina di Salerno, una ricchissima teoria di oggetti sfilerà tra le sale del MANN adiacenti il Salone della Meridiana, riaperte al pubblico nel 2017, dopo trent'anni.
Non mancano, in apertura del percorso, i riferimenti al contesto geopolitico - un’Italia fortemente divisa, all’arrivo dei Longobardi - e poi tracce del culto e dell’economia, con le monete utilizzate non solo come mezzo di scambio, ma anche come simbolo di ricchezza e prestigio, da sfoggiare come gioiello inserito in collane ed anelli.
In questo seducente percorso che grazie alle innovazioni della tecnologia presenta al pubblico ricostruzioni di sepolture, videomapping di monumenti e siti, postazioni immersive, sarà possibile riscoprire il fascino e l'importanza di un popolo che ha segnato un drammatico spartiacque nella storia italiana, pur cercando, al contempo, di ricostruire, su nuove basi, quell'unità perduta.
Leggi anche:
• Longobardi: una mostra "epocale" sul popolo che cambiò la storia
• Longobardi. Un popolo che cambia la storia
LA MAPPA
NOTIZIE
VEDI ANCHE
-
 Forlì-Cesena | Fino al 28 giugno al Museo di San Domenico
Forlì-Cesena | Fino al 28 giugno al Museo di San Domenico
Tutte le sfumature del Barocco in mostra a Forlì
-
 I programmi dal 23 al 29 febbraio
I programmi dal 23 al 29 febbraio
La settimana dell’arte in tv, da Brunelleschi a Matisse
-
 Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia
Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia
Giotto e San Francesco, alle origini della modernità
-
 Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio
Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio
La settimana in tv, dal Caravaggio perduto al mito di Tutankhamon
-
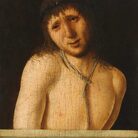 Torna in Italia il dipinto quattrocentesco
Torna in Italia il dipinto quattrocentesco
Tutto sull’Ecce Homo, il capolavoro di Antonello da Messina acquisito dallo Stato
-
 I programmi dal 9 al 15 febbraio
I programmi dal 9 al 15 febbraio
La settimana di San Valentino in tv, da Klimt a Basquiat


