Dall’11 ottobre la mostra ai Musei Reali
Torino celebra Guido Reni a 450 anni dalla nascita

Guido Reni, Lotta tra Amorini e Baccarini, 1613-1615 circa. Olio su tela. Musei Reali di Torino
Francesca Grego
10/10/2025
Torino - Per gran parte della vita lavorò a Roma e nella sua Bologna, lasciandovi dipinti straordinari. Ma ai nobili di casa Savoia Guido Reni piacque davvero tanto, fin dall’inizio. Ecco perché le sue opere non mancano nelle collezioni e nelle chiese del Piemonte. Lo racconta la nuova mostra in programma da domani, sabato 11 ottobre, ai Musei Reali di Torino, rendendo omaggio al pittore a 450 anni dalla nascita. Un’occasione per ammirare una parte forse poco nota della produzione del maestro emiliano, ma proprio per questo particolarmente preziosa. Nel percorso a cura di Annamaria Bava e Sofia Villano, accanto alle opere amate dai duchi - oggi di proprietà dei Musei Reali - troveremo i gioielli celati in chiese, cappelle e conventi del territorio, nonché significativi prestiti in arrivo dal Musée des Augustins di Tolosa. Da non perdere è una tela recentemente ritrovata, l’Assunzione della Vergine, scoperta nella chiesa di Abbadia Alpina a Pinerolo (Torino) e visibile per la prima volta dopo il restauro.
Lo stile luminoso e composto di Reni, l’armonia delle forme e quella bellezza ideale ereditata dalla scultura antica e e dai maestri del Rinascimento, si rivelarono particolarmente congeniali al gusto dei duchi di Savoia, pronti ad acquistarne i dipinti per adornare maestose residenze ed eleganti altari di corte. Il primo a subire il fascino del pittore bolognese fu il Principe Cardinale Maurizio ai primi del Seicento, all’alba del collezionismo sabaudo. Il nobile prelato soggiornò per lunghi periodi a Roma, dove ebbe modo di frequentare la raffinata corte di papa Urbano VIII Barberini. Estimatore della pittura classicista, il Cardinal Maurizio è noto per le importanti commissioni ad artisti bolognesi, spesso legate a complesse scene allegoriche. In seguito il principe Eugenio di Savoia Soissons riservò a Reni un posto d’onore nella propria quadreria: dopo la sua morte i dipinti del Divino furono acquistati da re Carlo Emanuele III, giungendo a Torino nel 1741.

Guido Reni, San Giovanni Battista, 1635 circa, Olio su tela, Musei Reali di Torino - Galleria Sabauda
Tra le oltre venti opere in mostra fino al prossimo 18 gennaio spiccano le due versioni di Marsia scorticato da Apollo: quella originariamente collocata nella “Camera delle Muse” del Palazzo Ducale, successivamente requisita dalle truppe napoleoniche nel 1799 e attualmente al Musée des Augustins di Tolosa, e la sua replica seicentesca conservata nella Galleria Sabauda. Il quadro spicca per l'invenzione compositiva con cui Guido Reni traduce in immagine un celebre episodio delle Metamorfosi di Ovidio, ovvero la punizione inflitta dal dio Apollo al satiro Marsia, colpevole di aver osato sfidarlo in una gara musicale. La composizione è dominata dalla figura idealizzata di Apollo, incarnazione della bellezza classica e della razionalità divina, in contrasto con il corpo martoriato e il volto straziato di Marsia, simbolo della tracotanza punita.
Passo dopo passo, Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte ricostruisce le vicende collezionistiche dei Savoia, evidenziando il ruolo dei maggiori estimatori dell’artista. Da non perdere sono le opere grafiche di Reni - che fu anche un disegnatore sopraffino - appartenenti al fondo della Galleria Sabauda e alle raccolte della Biblioteca Reale. E infine la maestosa pala dell’Assunzione della Vergine, da poco riscoperta nella chiesa di Abbadia Alpina, frazione di Pinerolo (TO), un tempo ricchissimo convento benedettino. La tela giunse in Piemonte per volontà dell’abate Ruggero Tritonio, che la commissionò a Reni all’inizio del Seicento. Il dipinto è esposto al pubblico per la prima volta in occasione della mostra, restituendo una preziosa testimonianza della prima attività romana del pittore, quando il giovane artista entra in contatto anche con la moderna pittura di Caravaggio.
Lo stile luminoso e composto di Reni, l’armonia delle forme e quella bellezza ideale ereditata dalla scultura antica e e dai maestri del Rinascimento, si rivelarono particolarmente congeniali al gusto dei duchi di Savoia, pronti ad acquistarne i dipinti per adornare maestose residenze ed eleganti altari di corte. Il primo a subire il fascino del pittore bolognese fu il Principe Cardinale Maurizio ai primi del Seicento, all’alba del collezionismo sabaudo. Il nobile prelato soggiornò per lunghi periodi a Roma, dove ebbe modo di frequentare la raffinata corte di papa Urbano VIII Barberini. Estimatore della pittura classicista, il Cardinal Maurizio è noto per le importanti commissioni ad artisti bolognesi, spesso legate a complesse scene allegoriche. In seguito il principe Eugenio di Savoia Soissons riservò a Reni un posto d’onore nella propria quadreria: dopo la sua morte i dipinti del Divino furono acquistati da re Carlo Emanuele III, giungendo a Torino nel 1741.

Guido Reni, San Giovanni Battista, 1635 circa, Olio su tela, Musei Reali di Torino - Galleria Sabauda
Tra le oltre venti opere in mostra fino al prossimo 18 gennaio spiccano le due versioni di Marsia scorticato da Apollo: quella originariamente collocata nella “Camera delle Muse” del Palazzo Ducale, successivamente requisita dalle truppe napoleoniche nel 1799 e attualmente al Musée des Augustins di Tolosa, e la sua replica seicentesca conservata nella Galleria Sabauda. Il quadro spicca per l'invenzione compositiva con cui Guido Reni traduce in immagine un celebre episodio delle Metamorfosi di Ovidio, ovvero la punizione inflitta dal dio Apollo al satiro Marsia, colpevole di aver osato sfidarlo in una gara musicale. La composizione è dominata dalla figura idealizzata di Apollo, incarnazione della bellezza classica e della razionalità divina, in contrasto con il corpo martoriato e il volto straziato di Marsia, simbolo della tracotanza punita.
Passo dopo passo, Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte ricostruisce le vicende collezionistiche dei Savoia, evidenziando il ruolo dei maggiori estimatori dell’artista. Da non perdere sono le opere grafiche di Reni - che fu anche un disegnatore sopraffino - appartenenti al fondo della Galleria Sabauda e alle raccolte della Biblioteca Reale. E infine la maestosa pala dell’Assunzione della Vergine, da poco riscoperta nella chiesa di Abbadia Alpina, frazione di Pinerolo (TO), un tempo ricchissimo convento benedettino. La tela giunse in Piemonte per volontà dell’abate Ruggero Tritonio, che la commissionò a Reni all’inizio del Seicento. Il dipinto è esposto al pubblico per la prima volta in occasione della mostra, restituendo una preziosa testimonianza della prima attività romana del pittore, quando il giovane artista entra in contatto anche con la moderna pittura di Caravaggio.
LA MAPPA
NOTIZIE
VEDI ANCHE
-
 Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio
Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio
I 150 anni di Brancusi ai Mercati di Traiano
-
 Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal
Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal
Signac presto in arrivo a Rotterdam
-
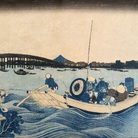 Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile
Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile
Il segno che diventa vita. Hokusai alla Galleria Elena Salamon di Torino
-
 Ancona | Dal 14 febbraio al 16 aprile
Ancona | Dal 14 febbraio al 16 aprile
Tiziano e Lorenzo Lotto insieme ad Ancona
-
 Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica
Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica
Bernini e i Barberini. La nascita del Barocco si racconta a Roma
-
 Mondo | Al Museum of Fine Arts dal 7 marzo al 31 maggio
Mondo | Al Museum of Fine Arts dal 7 marzo al 31 maggio
Unforgettable: Gand riscopre le artiste fiamminghe dimenticate


